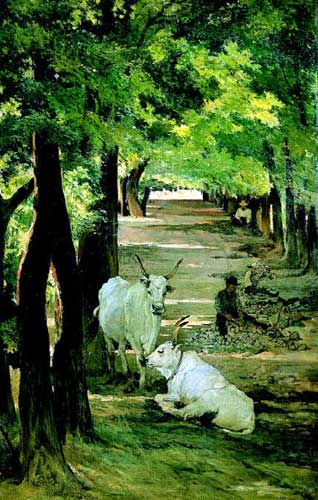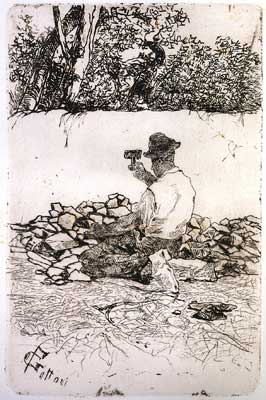|
La gestione
amministrativa e tecnica delle strade del Granducato fu
inizialmente prerogativa di due dei dieci Capitani di parte
Guelfa denominati Ufficiali dei fiumi, strade e ponti.
Con la legge dell'unione dei magistrati ad essi competeva
più prontamente che per il passato, rassettare le strade..
(1549). Questo nuovo ufficio era preposto ai lavori pubblici del
Contado e Distretto granducale, con l’eccezione del territorio
Pisano, ove operava l’Offizio dei Fossi di Pisa.
Tre anni dopo, il primo maggio 1551, con delibera Ducale, Cosimo
I° regolamentava questo nuovo Ufficio attribuendogli l’incarico
di provvedere al mantenimento, fra l'altro, delle fosse
principali e maestre, dei ponti sopra dette fosse e di quelli
già mantenuti per consuetudine dalle Comunità locali.
Seguivano le disposizioni per le spese per rassettare et
mantenere le strade a carico delle rispettive comunità e tra
le strade elencate troviamo la strada di marina da Livorno
alla Cecina, fino a Calafuria e la strada di Calafuria.
Nel 1578 fu emanato un bando che conteneva le norme per la
manutenzione delle strade o in cui si tornava a imporre ai
lavoratori locali lo svuotamento periodico delle fosse. Il bando
fu rinnovato nel 1680 , ma certo è, che questa manutenzione non
doveva sortire un grande effetto se, nel 1695, il Padre
Colombino e alcuni suoi compagni di viaggio, dopo un fortunoso
sbarco a Piombino, percorsero la strada costiera fino a
Montenero, arrivandovi stremati, poiché fu tale e tanto lo
stento l'andar lungo la marina, perché non sapevano la strada e
che in quella…così profonda vi consumarono tutte le scarpe,
calze e anco meno, che tutto l’abito, con tal stanchezza alle
ginocchia che già dubitavano non poter finire quel viaggio ...
A scadenze regolari si ripetevano gli ordini e bandi, che
ingiungevano, come quello del 1714, pena, severe sanzioni, a
tutti, sia padroni che fittuari, contadini e ortolani, di
provvedere nell'arco di tempo fra il l° agosto e il 31 ottobre,
alla pulizia e riassetto delle fosse, scoli, sgrondi ecc. lungo
le strade maestre e vicinali; come al divieto tassativo di
scaricare in dette strade, terra, letame, pietrami e altro che
ne ostruissero il passo o la guastassero facendo fanga….o
porre in opera strutture, scavi, pozzi, piante, che ne
restringessero o occupassero la carreggiata.
Quando nel 1737 si insediò Francesco I° di Lorena, nel
granducato Toscano erano ancora vigenti le Istruzioni ed
obblighi degli Ingegneri di Ponti e Strade emanate il 28
agosto 1718 sotto Cosimo III dei Medici. Gli Ingegneri di nomina
granducale, dipendevano ancora dalla Congregazione dei
deputati sopra le strade e ponti della Magistratura di Parte
Guelfa. Dovremo attendere fino al 1767 per avere nuove
disposizioni con L'istruzione per i cancellieri Comunitativi
all'oggetto che possano ben regolarsi nell’esecuzione di lavori
di strade. Significativo il fatto che venivano destinati ai
lavori sulle strade tutti quei soggetti miserabili, gli
estranei, i questuanti e gli sfaccendati che vivevano nel
vicariato, cui competeva la strada e che i contadini
erano comandati solo quando non richiesti dai lavori dei campi.
La figura del deputato di strade, prima chiamato agente,
acquistò importanza in relazione al fatto che da lui dipendeva
la verifica dei lavori appaltati dalle comunità e realizzati
secondo le linee operative indicate nella relazione
dell’ingegnere competente. Nel 1768 con motuproprio, il granduca
Pietro Leopoldo ribadendo la validità del regolamento emanato
nel 1718 , dava disposizione affinché il Senator
Soprassindaco de’ nove fosse equiparato nelle funzioni al
Senator Provveditore dell’uffizio della parte e che ambedue
dovessero sospendere quei Cancellieri delle Comunità che
avessero mancato nelle visite alle strade e quegli ingegneri che
avessero avvallato lavori difettosi con l’aggravio del
risarcimento del danno provocato al pubblico. Anche i muratori
che frodavano nei rifacimenti delle vie pubbliche e ponti
erano soggetti ad indennizzare e rifare a loro spese l’opere
difettose.
Arriviamo così, alla riforma Comunitativa del 1774 che distinse
le strade in due classi fondamentali: le Regie e le
Comunitative, oltre alle Vicinali e le private di uso
pubblico. Regie erano quelle costruite e mantenute a spese dello
stato, inizialmente soprattutto quelle classificate postali,
sulle quali da tempo l’amministrazione assicurava il cambio dei
cavalli e un servizio di ristoro per i viaggiatori, in luoghi
prestabiliti, le Stazioni di posta.
Le comunitative competevano ai comuni ed erano le strade, piazze
ponti e loro annessi esistenti entro le terre situate nel
territorio della comunità, e quelle che da detti luoghi
conducevano ai confini con altre comunità o che andavano da una
chiesa all’altra. Altra novità era l’abolizione delle
comandate dei lavoratori locali e degli abitanti del
territorio e la ridistribuzione dei carichi di spesa sui
proprietari terrieri confinanti con le strade, perché
contribuissero in proporzione ai lavori eseguiti a spese delle
casse comunitative. Due anni dopo, con una nuova legge, venivano
definitivamente rilasciate in accollo perpetuo alle
rispettive comunità nel territorio nelle quali sono situate,
addossando a ciascuna di esse il mantenimento di quel tratto, o
tratti di Strade Regie che si comprendono dentro la sua
estensione. Era data facoltà ai magistrati comunitativi di
deputare una persona di fiducia a trattare e convenire della
somma, e quantità delle prestazioni annuali da pagarsi alla sua
Comunità dalla Cassa dell’Entrata dell’Imposizione Universale
per le strade. I Comuni avrebbero potuto subappaltare il
lavoro di manutenzione delle strade a privati, traendone, se
possibile, un profitto; fermo restando la loro responsabilità
davanti all’Amm.ne dello stato, sull’eventuale cattivo stato
delle strade dovuto a negligenza o dolo degli appaltatori.
Nell’elenco allegato al documento, fra le Strade Regie soggette
alla nuova normativa vi è la Strada lungo marina di Livorno
per ogni parte lungo la spiaggia. La parentesi
dell'occupazione francese fu ricca di novità normative. Il 24
maggio 1804 venne emanata la Legge sulle strade che venivano
classificate in: Nazionali, Dipartimentali, Comunali e
Private. L'anno dopo le Dipartimentali furono inglobate
nelle nazionali. Tale regolamento fu applicato nel Regno
d’Italia fino al 1860. La strada del Litorale venne
contraddistinta con i numeri 193, 194 e 195 a seconda dei tratti
e classificata prima Regia, poi dal 1809 Imperiale, per tornare
Regia nel 1814. Nel l812, per renderla carrozzabile erano stati
previsti 800.000 franchi di spesa, ma i lavori non furono
eseguiti se non in minima parte ed in realtà nel tratto Livorno-
Cecina fu quasi sempre transitabile solo con i cavalli essendo
il traffico dei carri dirottato sulla Pisa - Cecina via
Collesalvetti. I Lorena nel 1825 istituirono, sul modello
francese un corpo tecnico altamente specializzato per la
costruzione e il mantenimento delle strade, gli Ingegneri di
ponti e strade, dividendo la Toscana in cinque compartimenti
secondo le provincie di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Grosseto,
dipendenti dalla Direzione generale di Acque e Strade cui
facevano capo i vari Ingegneri del Circondario.
Le strade furono classificate in: Regie postali, Regie non
postali, Provinciali e Comunitative Carreggiabili. La via
del Littorale che da Livorno conduce nella comunità di Campiglia
passando per i fortini fu classificata Regia. Nel 1840
risultava declassata a Provinciale a causa delle sue pessime
condizioni, ma i lavori eseguiti nello stesso anno portarono la
carreggiata a 12 braccia (circa 7 metri) di larghezza. A seguito
i questi lavori di consolidamento e rettifica del percorso, nel
1844 il Granduca la elevò di nuovo al rango "Regia" strada nel
tratto da Livorno a Vada, e con esso il piccolo tronco che da
Vada collegava alla via Regia Emilia.
La principale e più
antica arteria romana del territorio era la Via Aurelia,
costruita a partire dal 241 a.C., il cui percorso costiero
collegava Vada con gli altri porti. Successivamente (fra il 115
e il 109 a.C.) la Via Aemilia Scauri ne prolungò e ne
razionalizzò il tracciato. Il suo percorso, documentato da
pietre miliari e da fonti itinerarie, è più interno di quello
dell'Aurelia: a Nord di Vada essa proseguiva per Pisae con un
tracciato in parte coincidente con l'attuale SS 206.
(Da: "Guida
al Museo Archeologico di Rosignano Marittimo" di E.Regoli e
N.Terrenato)
Una delle
componenti fondamentali del paesaggio rurale è rappresentata
dalle strade, nelle loro molteplici varietà. Le più importanti
erano carrabili, le altre soltanto somabili, comunque fossero mulattiere,
sentieri, viottole di campagna, "strade regie" e "comunitative",
contribuivano a tessere una rete viaria più o meno fitta a
seconda del grado di popolamento delle varie zone. Molti di
questi percorsi vantano origini medievali e, in alcuni casi,
addirittura più antiche: resti di acciottolato, delimitato da un
cordone di pietre o sostenuto da muretti a retta, denotano la
vetustà del tracciato. Segno tangibile di una lontana origine, è
anche la presenza del verde ornamentale (soprattutto filari di
cipressi), o segnaletico (piante isolate alle biforcazioni),
così come le testimonianze di pietà religiosa (tabernacoli e
croci) che s'incontrano lungo il percorso.
(Da: "I segni storici del paesaggio rurale" di Roberto
Branchetti)
Dagli estimi
del XVI secolo, si rileva che la principale via che serve
questo territorio è la Strada Maremmana, chiamata anche Pisana (Oggi S.S.
206, Pisana-livornese).
Il suo percorso era più o meno quello attuale, corrispondente
al tracciato della via Emilia. Dal borgo di Rosignano si
dipartiva una strada, la via "publica", importante per la
zona, che andava verso Vada. Sul suo itinerario, vicino a
Rosignano, vi era lo Spedale di Sant'Antonio che dava
assistenza ai bisognosi e ai pellegrini; la strada
attraversava il torrente Fine al Ponte di Vada, nella zona
detta Prata a Isola o Sabbine, vicinissima all'attuale guado,
e da lì percorreva la proprietà dell'Arcivescovado di Pisa.
Alla fine del 1700 questa strada, detta via di Sant'Antonio,
risultava essere la più importante e rappresentativa del
comprensorio comunitativo di Rosignano: ne attraversava
l'intero territorio, ed era la via più grande come dimensione
in carreggiata, rivestiva inoltre un ruolo di rilievo anche
sotto il profilo economico, collegando l'intero circondario al
porto di Vada. Infatti la via Maremmana, proveniente da Pisa,
nel tratto relativo alla Comunità di Rosignano a sud
dell'osteria dell'Acquabona, affrontando il poggio del
Malandrone, diventava una strada secondaria, disagevole, poco
frequentata, e per questo adatta al brigantaggio, per cui il
traffico dall'incrocio dell'Acquabona, si dirottava verso il
Borgo di Rosignano, sia per scambi commerciali, sia per una
sicurezza personale e delle merci. Dopo il paese, il passaggio
continuava verso sud immettendosi sulla via di Sant'Antonio.
Questa via, giunta in prossimità del fiume Fine, presso
l'osteria e mulino del Riposo, si diramava in due tronchi, uno
diretto verso il porto di Vada mentre l'altro, attraversata la
"Tenuta" vescovile, si collegava di nuovo con la via
Maremmana.
Da:
"Una comunità della Toscana Lorenese: ROSIGNANO
(1765-1808) Popolazione, Insediamento ed Ambiente" (1989) di Stefano Rossi e P.L.Ferri.
Il rinnovamento della rete stradale realizzato all'inizio
dell'800 da un impulso vigoroso alla rinascita dell'area che
da qui comprende anche la Maremma. Nel 1843 il "Giornale
Agrario" scrive:
"Il benefizio
che hanno recato alla Maremma le strade rotabili è immenso.
Era questo un paese affatto segregato dal resto del
Granducato. Posti in agevole comunicazione tra loro i
diversi punti della Maremma, e questi con le altre parti
della Toscana, immediatamente si sono stabilite nuove
relazioni di traffico...
"
La nuova
viabilità produce cambiamenti straordinari nelle abitudini
delle persone, soprattutto della povera gente che deve
raggiungere la Maremma per le grandi "lavorie" d'estate e
d'autunno, poveri lavoranti avventizi delle montagne
appenniniche. Essi, lasciata
"l'antica,
renosa, cupa e solitaria via Emilia per una via nuova,
comoda, aprica e frequente, dalla quale se ne diramano altre
più o meno buone e piacevoli che mettono con essa in
comunicazione i vari paesi e possessi, incominciarono a
servirsi dei barrocci sopra i quali viaggiano più
economicamente di quello che farebbero andando a piedi... "
Il breve brano che segue da la misura di quanto grande fosse
la miseria umana e morale di chi era costretto a percorrere
queste strade cercando un po' di lavoro per sopravvivere:
"Accadeva che i montagnoli dopo aver passato l'invernata
lavorando in Maremma, ritornando oppressi dalle fatiche,
nella lunghezza del viaggio e affannati per il calore
intempestivo, riposandosi o dormendo sotto un albero...
erano sopraggiunti da ardentissima febbre, che li spingeva
spesso, trovandosi senza soccorso, al sepolcro. E quando non
accadeva tanto disastro, erano forzati di spendere alle
osterie più di quello che oggi pagano per farsi trasportare
sui barrocci, impiegando nel viaggio la quarta parte del
tempo che vi impiegavano allora. Ne queste fermate erano
comode per loro, essendo spesso ricevuti con pessime
maniere, fino al punto di ricevere improperi, dei quali io
stesso sono stato testimone, sentendoli chiamare "indiscreti
ed esigenti", da un oste, che usava il suo vocabolario,
perché essendo quattro non si contentavano di due sole
forchette per mangiare".
Le
migliorate comunicazioni promuovono nuove iniziative: i
paesi brulicano di vetturali e i trasporti diminuiscono
grandemente di prezzo; sulle nuove strade vengono stabilite
regolari comunicazioni, prima ad opera del governo, poi su
iniziativa privata, quando diventa evidente il vantaggio
economico.
Da: "Quaderni Vadesi" n° 5 di
Carla Menghini Facchini |
|
"LO
SPACCAPIETRE"
(da: Veglie di Neri di Renato Fucini)
Quando il sole piomba infocato sulle groppe stridenti delle
cicale, e il ramarro, celere come l'ombra d'una rondine,
attraversa a coda ritta la via; o nel tempo che la bufera
arriccia e spolvera all'aria l'acqua delle grondaie
ficcandoti nell'ossa il freddo e la noia, lo spaccapietre è
al suo posto. Un mazzo di frasche legate a ventaglio in cima
d'un palo lo difende dal sole nell'estate; un povero
ombrello rizzato fra due pietre e piegato dalla parte del
vento, lo ripara dalla pioggia nell'inverno.
Il barrocciaio che la mattina passa scacciando con una
frasca i tafani di sotto alla pancia del mulo trafelato, gli
dà il buon giorno; il contadino, tornando la sera fradicio e
intirizzito dai campi, gli augura la buona notte.
E all'ombra di quelle frasche o sotto il riparo di quell'ombrello,
seduto sopra una pietra bassa e quadrata, consuma le sue
lunghe giornate, finché la massa di macigni che la mattina
stava alla sua sinistra non è passata all'altra parte,
ridotta dal suo pesante martello in minuti frantumi di
breccia acuta e tagliente.
Allora egli è contento, perché ha guadagnato gli ottanta
centesimi che gli paga puntualmente l'accollatario del
mantenimento della via. Ma non sempre gli va così. Non
perché l'accollatario, che è un vero galantuomo, sia capace
di defraudarlo; ma perché molte sono le cause che possono
assottigliargli il guadagno o allontanarlo affatto dal
lavoro. Di frequente la pietra che ha da spezzare è troppo
forte, e il lavoro non gli comparisce; qualche volta gli si
guasta il martello, e perde tempo a riadattarlo; non di rado
nell'inverno il maltempo infuria così impetuoso che lo
scaccia dal lavoro; spesso, quando il sole d'agosto è troppo
rovente, è costretto a cercare d'un albero e quivi all'ombra
riposarsi, perché sente che le forze gli mancano; qualche
altra volta, col braccio tremante per la stanchezza, e
questo accade più spesso, cala il martello in falso e si
percuote sul dito, ammaccandoselo sempre dolorosamente, non
di rado fino al sangue. E in quel caso gli tocca a fasciarsi
o a correre alla più vicina fontana, se pure non deve
abbandonare il lavoro, perché lo spasimo non gli permette di
continuare. E i cinquanta e gli ottanta centesimi allora non
vengono, e la fame si ferma alla sua casa e lo veglia e
l'assiste e non l'abbandona, finché non l'ha ricondotto
estenuato e pallido presso il monte di pietre che da otto
giorni l'aspetta lungo la via. E quella sera mangerà;
mangerà poco, perché poco potrà lavorare; ma l'accollatario,
che per fortuna è un vero galantuomo, gli misurerà
puntualmente il lavoro fatto, e puntualmente gli darà i suoi
venti o trenta centesimi trascurando i rotti in più della
misura, perché lui a queste piccolezze non ci bada; ha
trattato sempre bene chi lavora, e se ne vanta.
Io ne conosco uno di questi splendidi esemplari di carne da
lavoro. Ah! ma questo che conosco io è stato sempre un
signore, il Creso degli spaccapietre, perché fino a sessant'anni
sonati, stomaco di cammello e muscoli di leone, ha
guadagnato sempre il massimo che può fruttare il suo lavoro,
e la polenta gialla o il pane bigio non sono mai spariti
altro che per eccezione dalla sua tavola.
E i suoi colleghi lo rammentano con ammirazione, e
raccontano ai loro amici attoniti come tutto l'inverno del
'57 fu capace di spezzare due metri cubi arditi di pietra
ogni giorno che Dio metteva in terra, senza mai fumare,
senza bere un dito di vino e senza ammalarsi.
Ma le sue mani paiono due pezzi informi di carne callosa, il
suo viso, screpolato piuttosto che solcato da rughe, pare un
pezzo di pane da cani, e i suoi occhi, dopo tanti anni di
sole, di polvere e d'umidità, sono contornati di rosso e gli
lacrimano di continuo nelle occhiaie infiammate, che la
notte gli bruciano e non gli dànno riposo. Ha le gambe torte
e rigide dal lungo starsi a sedere, la schiena fortemente
curvata, il corpo intero di mummia, lo spirito consumato dai
dolori.
Se gli domandi delle sue sventure, egli ti agghiaccia col
racconto freddo e conciso che, tra un colpo e l'altro del
suo martello, te ne fa come di cose che debbano
necessariamente accadere.
La sua figliola maritata partorì alla macchia dove era
andata a far legna, e fu trovata morta lei e la creatura; il
genero, che pareva tanto un buon giovane, scappò con una
donnaccia e finì per le prigioni dopo avergli lasciato un
nipotino che era la sua consolazione. Ma anche quello il
Signore lo volle per sé, perché si vede che non lo credeva
degno di tanta fortuna. Quando parla della figliola e del
genero, non dà segni di commozione; ma se rammenta il su'
povero Gigino posa il martello, si prende la testa fra le
mani e, dondolandola come fa l'orso nella gabbia, racconta
la sua fine pietosa.
Aveva già cominciato a menarlo con sé a spezzare, perché era
un ragazzetto che per la fatica prometteva dimolto, quando
un giorno, povero Gigino! non potendo più reggere dalla sete
che lo tormentava dopo aver mangiato una salacca senza
lavare, entrò in un campo e s'arrampicò sopra un ciliegio.
Sopraggiunse il contadino gridando da lontano; il bambino
per scender presto, cadde, si fece male a una gamba, non
poté fuggire e fu mezzo massacrato dal contadino che lo
raggiunse. Parte per lo spavento, parte per le percosse,
dopo quindici giorni gli morì di convulsioni, che tutti non
fecero altro che dire «Peccato!», perché delle creature
belle a quella maniera non era tanto facile vederne.
Finito il racconto, rimane un momento fermo a pensare; poi
ripiglia il martello e continua il suo lavoro.
La sua donna è cieca da un occhio, e di quella disgrazia la
colpa l'ha tutta lui, perché, se ci avesse badato, non
sarebbe accaduta. Quando le gambe la reggevano, la mattina
andava a chiedere l'elemosina, e, se aveva fatto qualche
tozzo di pane, verso il mezzogiorno glielo portava dove era
a spezzare e si fermava lì a tenergli un po' di compagnia; e
qualche volta, in tempo che lui mangiava, si metteva lei a
spezzare, tanto per non perder lavoro. Una mattinaccia, in
tempo che la su' donna svoltava la pezzòla del pane, passò
un signore in calesse che buttò via un mozzicone di sigaro
acceso, il quale andò a cascare vicino al monte de' sassi.
La donna si chinò per raccattarlo e porgerlo al marito, e in
quel tempo una scheggia d'alberese la colpì nell'occhio e
l'accecò senza rimedio. Da quella mattina non è stata più
lei: gli dole sempre il capo, non si regge più ritta dalla
debolezza e non sa come curarsi, perché il dottore non gli
ha ordinato altro che carne e vino generoso. E ora passa le
sue giornate sull'uscio, seduta a chiedere la carità ai
viandanti; ma da che hanno fatto la strada ferrata non passa
quasi più nessuno, e spesso, dopo essersi accostata, mezza
cieca, a chieder l'elemosina a chi le viene incontro per
chiederla a lei, vede andar sotto il sole senza aver fatto
né un centesimo né un boccone di pane. Allora, s'accuccia
per abitudine accanto al fuoco spento, dove, aspettando il
marito e dicendo la corona, s'addormenta.
Un giorno che, meno brusco del solito, mi parlava delle sue
miserie, dei suoi bisogni e delle sue privazioni, gli
domandai quasi scherzando:
«Dimmi: se tu potessi in questo momento ottenere tutto
quello che ti paresse, che desidereresti?»
«Una fetta di pane bianco per darlo inzuppato alla mi'
vecchia che non ha più denti!»
Ma quando quest'uomo s'ammalerà, il medico, andando a suo
comodo dopo la terza chiamata, lo troverà agonizzante; il
prete invitato per carità a spicciarsi, vorrà finire il suo
desinare e lo troverà morto; il becchino, guardandogli i
piedi scalzi e il camicione topposo, gli reciterà la breve
orazione: «Accidenti a chi ti ci ha portato!».
Il volume "Veglie di Neri" è
scaricabile dal sito alla sezione Scaricolibri
"LO SPACCAPIETRE"
(da: 'Un ragazzo in toscana negli
anni quaranta' di Piero Santi)
Ho accennato prima a questo mestiere e ritengo sia opportuno
specificare meglio in cosa consisteva. Le strade bianche,
quelle non asfaltate, erano la maggioranza nell’Italia
centrale. Fino agli anni Cinquanta queste strade venivano
mantenute con ghiaia derivata da pietra di fiume ossia
ciotoli rotondeggianti di arenaria rotti a mano. Una figura
che è rimasta molto presente nei ricordi della mia
generazione è quella degli spaccapietre. Erano degli uomini
di mezza età, per quanto ricordo, assai loquaci e integrati
nel tessuto del contado. Ecco come si svolgeva il loro
lavoro. Un barroccio, trainato ovviamente da un cavallo,
scaricava dei cumuli di pietre di fiume di circa mezzo metro
cubo ognuno sulla banchina della strada, a distanza di una
cinquantina di metri l’uno dall’altro. Un uomo si sedeva su
una balla riempita di paglia, messa a cavallo della pietra
più comoda, così seduto prendeva in mano un sasso alla volta
e con un martello speciale, adatto all’uso a cui era
destinato, riduceva quelle pietre in piccoli pezzi di forma
irregolare, ma di 20-30 grammi.In una giornata di lavoro
ingrato, sotto il sole, lo spaccapietre, impolverato dalle
rare auto che passavano, sminuzzava un po’ più di mezzo
metro cubo di pietre. Le sue mani erano callose, rigide,
ruvide sino all’inverosimile. Se gli davamo la mano era come
stringere una grattugia di ferro (come quelle con le quali
normalmente si grattugia il formaggio). L’uomo conosceva
tutti: i barrocciai, i contadini che passavano con i loro
carri trainati da buoi, quelli che andavano a piedi al paese
o al mercato. Per molti “pendolari” che passavano due volte
al giorno per andare al lavoro e ritornare, lo spaccapietre
era un punto di riferimento, anche un confidente e perfino
un apportatore di tranquillità contro persone non
rassicuranti che saltuariamente transitavano. “Attenzione
donne, chiudete gli usci, badate i bimbi! Son passati gli
zingari; lo sapete che quelli portano via anche i bimbi...
!“ Forse era un allarme ingiusto quello dei bimbi, ma
certamente serviva come avviso per difendersi dai piccoli
furti. Quando non c’erano passanti il buon omo, tra una
martellata e l’altra, cantava. Per lo più erano stornelli il
cui contenuto era spesso una rievocazione di fatti lontani.
Finito di spaccare il mucchio, con il badile raccoglieva
questi detriti divenuti ghiaia e li ammucchiava sì da
formare una specie di tronco di piramide. Lo stradino
dipendente dall’A.N.A.S. dalla Provincia o dal Comune,
responsabile del tratto di strada, passava a misurare il
volume del mucchio e, in base a questo, lo spaccapietre
riscuoteva; forse ricavava una quindicina di lire al giorno,
più di un bracciante agricolo che ne prendeva dodici. Per
dare un ragguaglio dei valori, ricordo che un buon vino
veniva venduto al minuto a circa cinque lire al litro, ma
tre lire all’ingrosso. Il prezzo di un paio di buoi da tiro
era di dieci-dodicimila lire. Evidentemente uno che
guadagnava anche quindici lire al giorno, poteva fare “pochi
salti”. |