|
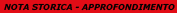 Il cammino dei pastori
Il cammino dei pastori
Con l'autunno arrivava il tempo della transumanza, i pastori lombardi
intraprendevano un viaggio che sarebbe durato dai sette ai
quindici giorni verso territori un tempo facenti parte di un
unico immenso feudo, lungo strade regie e i tratturi detti poi,
vie Maremmane o Doganali.
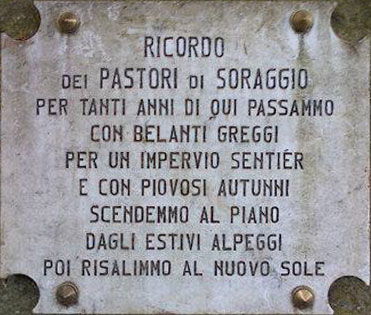 Dopo le importanti feste di settembre
(la Natività della Madonna, l'Esaltazione della Croce, san Michele) e fatti i contratti, a novembre, quando cominciava a
far veramente freddo, a piedi, o i più fortunati con un asino,
un cavallo o un mulo sopra il quale caricavano le masserizie, i
pastori si mettevano alla guida dei greggi delle pecore e delle
capre da far svernare in luoghi più caldi per la vicinanza del
mare, come ricorda questa lapide nel paese di Soraggio sulle
Apuane. Portavano con loro la farina dolce di castagne che
avevano raccolto e macinato per venderla agli abitanti della
costa, ma anche prodotti di contrabbando (sete, lane) o di
artigianato. Spesso avevano dietro i ragazzi da impiegare come
garzoni, o delle donne da maritare o far lavorare come
domestiche e non mancavano i cani da difesa. Poteva
accompagnarli anche qualche altro emiliano: un carbonaio o un
fabbro, un sensale di bestiame, qualche mercante di stoffe
milanese, o un terraticante che era uno dei lavoratori
della terra più poveri. Arrivati nei paesi di Maremma i pastori
effettuavano quelle pratiche che il Comune richiedeva sia per la
riscossione delle gabelle, che per l'ordine pubblico. Prendevano
alloggio in un domicilio coatto, un capannone o una casa
attrezzati al bisogno che aveva nome di masseria. Quella
del Gabbro, documentata molto tardi (1566), ospitava un migliaio
di ovini e due cavalli per varie incombenze. Qui avevano
riferimento in un capo pastore, un emiliano o uno del posto che
si era aggiudicato l'asta dei proventi del pascolo e vigilava
sul rispetto di varie norme. Al Gabbro fu detto in vari tempi
conduttore, paschiere, proventuario; altrove ebbe il nome di
vergaio. Erano suoi sottoposti dei garzoni o butteri che si
occupavano del trasferimento e del soggiorno degli animali. La
masseria del Gabbro dovette essere collegata anche all'osteria,
uno dei nomi con cui era chiamato il provento pubblico del vino
e del macello. Spesso l'asta veniva fatta a settembre, cioè non
molto prima dell'arrivo dei greggi emiliani. Vino, carne, ma
anche pane e frutta servirono certamente a chi era costretto a
restare per mesi; ed è per questo che in vari documenti si
possono trovare anche osti interessati alla conduzione dei
pascoli. Per esempio nel 1360 i poderi di Uliveto, Salviano,
Leccio, Tregolo, ecc., vennero allogati ad Antonio di
Ugolino tavernaio di Livorno; nel 1427 era un tale Francesco di
Jacopo di Nugola taverniere che conduceva dall'Opera del Duomo
di Pisa la quarta parte del pasco e la pastura di Uliveto e
Limone (sono i territori vicini al Gabbro). Trascorreva
l'inverno. Tra aprile e maggio gli emiliani riportavano le
pecore e le capre sui monti, insieme a vari prodotti delle
Maremma non coltivabili sugli Appennini (vino, olio, grani
saraceni). Sia all'andata che al ritorno lungo le strade maestre
una fitta rete di ospizi veniva incontro ai bisogni dei pastori:
un pasto, un tetto se pioveva forte, un letto se si era
ammalati, informazioni sulla strada da seguire. Se non c'era
l'ostello, lungo le vie si poteva trovare una indicazione
particolare: un tabernacolo per esempio, e dalla iconografia dei
santi si poteva
intuire la vicinanza di un luogo sacro. Al Gabbro fu prossima
al paese per molti secoli una Maestà: se ci volessimo domandare
il significato dei santi raffigurati nell'immagine del
tabernacolo - la Madonna, san Michele, sant'Antonio abate -
capiremmo dal dipinto di essere vicini ad un castello e ad una
chiesa dal titolo a san Michele e ad un luogo sacro dedicato
alla Madonna, abitato da religiosi regolari, simboleggiati da sant'Antonio abate (v. la Sambuca e Montenero, ma anche Popogna
dove fu una cappella proprio con il titolo a sant'Antonio). Nel Medioevo
e forse anche in tempi più lontani esisteva la possibilità per
gli stranieri di poter prendere alloggio presso case o quartieri
pubblici creati da sovrani o autorità comunali. Questi alloggi
coatti incentivavano e controllavano il commercio a lunga distanza.
Sebbene nel Basso Medioevo si sappia di una loro graduale scomparsa, ci
sembra che possa rientrare in questa categoria, come piccolo fondaco
rurale, la masseria del Gabbro. Da: "Gabbro, gente, terre e documenti" di Paola Ircani Menichini, Corrado Palomba, Lando Grassi) scaricabile
dal sito. Dopo le importanti feste di settembre
(la Natività della Madonna, l'Esaltazione della Croce, san Michele) e fatti i contratti, a novembre, quando cominciava a
far veramente freddo, a piedi, o i più fortunati con un asino,
un cavallo o un mulo sopra il quale caricavano le masserizie, i
pastori si mettevano alla guida dei greggi delle pecore e delle
capre da far svernare in luoghi più caldi per la vicinanza del
mare, come ricorda questa lapide nel paese di Soraggio sulle
Apuane. Portavano con loro la farina dolce di castagne che
avevano raccolto e macinato per venderla agli abitanti della
costa, ma anche prodotti di contrabbando (sete, lane) o di
artigianato. Spesso avevano dietro i ragazzi da impiegare come
garzoni, o delle donne da maritare o far lavorare come
domestiche e non mancavano i cani da difesa. Poteva
accompagnarli anche qualche altro emiliano: un carbonaio o un
fabbro, un sensale di bestiame, qualche mercante di stoffe
milanese, o un terraticante che era uno dei lavoratori
della terra più poveri. Arrivati nei paesi di Maremma i pastori
effettuavano quelle pratiche che il Comune richiedeva sia per la
riscossione delle gabelle, che per l'ordine pubblico. Prendevano
alloggio in un domicilio coatto, un capannone o una casa
attrezzati al bisogno che aveva nome di masseria. Quella
del Gabbro, documentata molto tardi (1566), ospitava un migliaio
di ovini e due cavalli per varie incombenze. Qui avevano
riferimento in un capo pastore, un emiliano o uno del posto che
si era aggiudicato l'asta dei proventi del pascolo e vigilava
sul rispetto di varie norme. Al Gabbro fu detto in vari tempi
conduttore, paschiere, proventuario; altrove ebbe il nome di
vergaio. Erano suoi sottoposti dei garzoni o butteri che si
occupavano del trasferimento e del soggiorno degli animali. La
masseria del Gabbro dovette essere collegata anche all'osteria,
uno dei nomi con cui era chiamato il provento pubblico del vino
e del macello. Spesso l'asta veniva fatta a settembre, cioè non
molto prima dell'arrivo dei greggi emiliani. Vino, carne, ma
anche pane e frutta servirono certamente a chi era costretto a
restare per mesi; ed è per questo che in vari documenti si
possono trovare anche osti interessati alla conduzione dei
pascoli. Per esempio nel 1360 i poderi di Uliveto, Salviano,
Leccio, Tregolo, ecc., vennero allogati ad Antonio di
Ugolino tavernaio di Livorno; nel 1427 era un tale Francesco di
Jacopo di Nugola taverniere che conduceva dall'Opera del Duomo
di Pisa la quarta parte del pasco e la pastura di Uliveto e
Limone (sono i territori vicini al Gabbro). Trascorreva
l'inverno. Tra aprile e maggio gli emiliani riportavano le
pecore e le capre sui monti, insieme a vari prodotti delle
Maremma non coltivabili sugli Appennini (vino, olio, grani
saraceni). Sia all'andata che al ritorno lungo le strade maestre
una fitta rete di ospizi veniva incontro ai bisogni dei pastori:
un pasto, un tetto se pioveva forte, un letto se si era
ammalati, informazioni sulla strada da seguire. Se non c'era
l'ostello, lungo le vie si poteva trovare una indicazione
particolare: un tabernacolo per esempio, e dalla iconografia dei
santi si poteva
intuire la vicinanza di un luogo sacro. Al Gabbro fu prossima
al paese per molti secoli una Maestà: se ci volessimo domandare
il significato dei santi raffigurati nell'immagine del
tabernacolo - la Madonna, san Michele, sant'Antonio abate -
capiremmo dal dipinto di essere vicini ad un castello e ad una
chiesa dal titolo a san Michele e ad un luogo sacro dedicato
alla Madonna, abitato da religiosi regolari, simboleggiati da sant'Antonio abate (v. la Sambuca e Montenero, ma anche Popogna
dove fu una cappella proprio con il titolo a sant'Antonio). Nel Medioevo
e forse anche in tempi più lontani esisteva la possibilità per
gli stranieri di poter prendere alloggio presso case o quartieri
pubblici creati da sovrani o autorità comunali. Questi alloggi
coatti incentivavano e controllavano il commercio a lunga distanza.
Sebbene nel Basso Medioevo si sappia di una loro graduale scomparsa, ci
sembra che possa rientrare in questa categoria, come piccolo fondaco
rurale, la masseria del Gabbro. Da: "Gabbro, gente, terre e documenti" di Paola Ircani Menichini, Corrado Palomba, Lando Grassi) scaricabile
dal sito.
******
I pastori, con rescritto di S.A.S. del 16 maggio 1633, furono
autorizzati ad essere armati, malgrado il disappunto delle autorità a
far portare armi ai popolani, quando accompagnavano le bestie al pascolo
per difenderle dai banditi e dai lupi; segno questo delle condizioni del
contado in quei tempi!
(Da: "Il Capitanato Nuovo di Livorno" di Renzo Mazzanti) |

