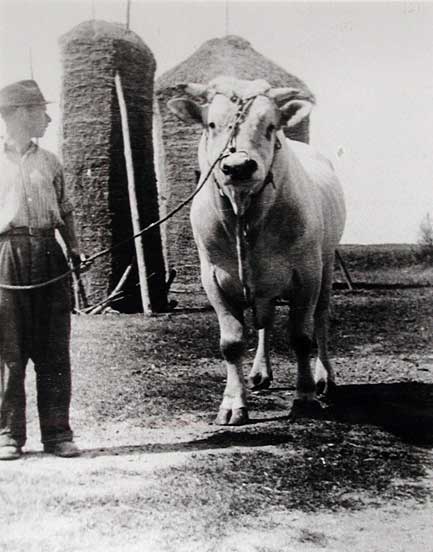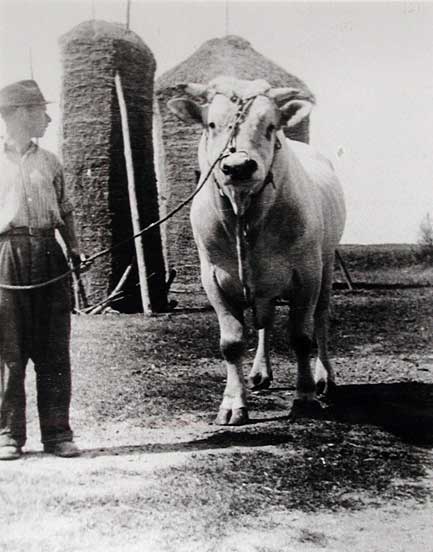|
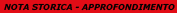 L'evoluzione del lavoro
nel '900
L'evoluzione del lavoro
nel '900
Il lavoro nei primi anni del '900 era prevalentemente agricolo, esercitato
da contadini e piccoli possidenti. I contadini facevano capo alle
rispettive fattorie; tra queste ricordiamo la fattoria Mirabella, quella
in località Poggiopiano e quelle più piccole, come numero di
agricoltori, delle Ceretelle e della Villa. Il lavoro si svolgeva tutto a
mezzadria e i prodotti venivano portati alle fattorie e poi suddivisi. I
campi venivano lavorati dagli stessi contadini e possidenti con attrezzi
di vario genere: zappe, aratri trainati da buoi e più tardi da qualche
trattore. Il raccolto era ed è tuttora, costituito da grano, orzo,
granoturco, fieno, olive, uva, ecc. Caratteristica era la vendemmia; l'uva
raccolta veniva portata in appositi recipienti e pigiata da persone a
piedi scalzi o con il « pigio»,
ramo di albero appositamente conservato per questo uso, dopodiché gettata
nei tini o nelle apposite botti per la fermentazione. Nel mese di
settembre la raccolta dell'uva costituiva un lavoro stagionale per le
donne, le quali raccoglievano e pulivano i bei grappoli che poi venivano
posti in ceste ed avviati nei vari mercati italiani ed esteri. Bella era
anche la mietitura del grano eseguita a mano con la falce, da mattina a
sera, o con la segatrice trainata da buoi o dal trattore. Al termine del
lavoro la massaia, cioè al calar del sole, usava portare, in un grosso
paniere, la cena che veniva consumata all'aperto con grande appetito. Il
grano veniva poi portato nell'aia dove era eretta coi covoni la "barca"
e, successivamente, si effettuava la trebbiatura in mezzo ad un gran
polverone. La trebbiatrice veniva azionata dal cosiddetto vaporetto
(macchina a vapore) attraverso una lunga cinghia di trasmissione. Il
vaporetto funzionava, in un primo tempo a legna, dopo a carbone. Col
passare del tempo fu sostituito dal trattore, il cui combustibile era
petrolio agricolo. Oggi invece sia la mietitura e tutte le conseguenti
operazioni, vengono effettuate simultaneamente nei campi da macchine
tecnicamente avanzate e che richiedono poca mano d'opera e minor perdita
di tempo. Altre persone, donne, ragazzi e disoccupati, si recavano nei
campi dove era stato segato il grano, a «spigolare», cioè a raccogliere
le spighe che erano state lasciate nel campo, inavvertitamente dalle
raccoglitrici. Chi aveva spigolato, una volta tornato a casa, in un
piazzale, batteva le spighe con due bastoni snodati chiamati
«correggiati » e dopo
averle spulate al vento portava i chicchi di grano, puliti, al mulino per
macinarli. Altri operai trovavano lavoro, se pur saltuariamente, a
tagliare boschi, a portare legna coi muli o lungo le strade a spaccare
pietre necessarie per rifare il fondo stradale, e alla « Magnesite»
nel versante a mare tra Nibbiaia e Castiglioncello, dove venivano estratti
materiali refrattari. Le donne, oltre a collaborare con gli uomini in
molti lavori, accudivano alle faccende di casa e facevano il pane che
cuocevano nei forni scaldati a legna. Il lavoro rendeva poco e la miseria
regnava ovunque, imponendo grossi sacrifici anche nell'alimentazione che
era più che frugale a base di fagioli, patate, polenta, aringhe, erbe di
campo, ecc. La carne, il coniglio o il pollo venivano, in genere, mangiati
nei giorni di gran festa. Per alcuni la situazione migliorò un poco
quando un certo numero di operai fu assunto a lavorare presso la fornace
Serredi, presso lo stabilimento Solvay e in alcune fabbriche di materiale
bellico a Livorno. Dal 1935 al 1944 la situazione, anche a causa della
guerra, restò stazionaria. Nel 1945 il lavoro riprese intensamente
ovunque. Gli americani, giunti nelle nostre zone durante la seconda guerra
mondiale, fecero di Livorno, per il suo porto, un centro base di
installazioni militari. Riattivarono le fabbriche distrutte dai bombardamenti
e installarono numerosi magazzini dando lavoro a migliaia di operai. Molti
venivano prelevati al mattino con camion militari anche dal Gabbro e
portati in questi centri di lavoro e la sera riportati alle loro case.
percorrendo in un primo tempo, la via di Valle Benedetta, perchè la via
della Popogna era impraticabile per i danni provocati dai tedeschi, i
quali, prima della ritirata, avevano fatto saltare tutti i ponti. Il
notevole contributo di lavoro dei gabbrigiani per la ricostruzione e per
la ripresa economica della città di Livorno e la loro voglia di lavorare
in ogni settore, hanno fatto sì che oggi abbiano raggiunto, in genere, un
meritato benessere economico. Per questo, fra gli impresari edili e loro
lavoratori, vanno menzionati i Sigg. Geom. Mario Barzacchi, Libero
Trusendi, Rag. Ivo Ferretti, Ing. Ivanio Castagni, Monastero Gori, Marino
Malanima, Alfonsino Piancastelli e Alessandro Giusti e vanno ricordate le
Cooperative Edili L'Aquila, Sirena, Rondine e Verriga, tutti residenti al
Gabbro. Dopo il 1945 molti giovani agricoltori lasciarono i lavori dei
campi per andare a lavorare nelle industrie e l'esodo fu così intenso che
molte famiglie di agricoltori cessarono di esistere come tali e molti
poderi furono abbandonati. Oggi questi campi vengono lavorati a conduzione
diretta. Anche la fattoria di Poggiopiano cessò il suo ruolo perchè fu
acquistata dalla Compagnia Portuale di Livorno e trasformata in ente
sociale agricolo, passando ad una prevalente produzione di vini. Nei
gabbrigiani l'emigrazione all'estero per lavoro ha sempre trovato
poco riscontro; emigrarono in Argentina con le famiglie Vasco Spinelli
che, dopo molti anni di permanenza in quella nazione, tornarono al loro
paese; Otello Pozzi emigrò in USA e sempre in USA emigrò Massino Massini
che seguì le figlie che avevano sposato due americani.
Da:"Il
mio paese Gabbro" di Jacopo Cadore Quochi 1979, scaricabile dal sito
|