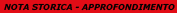 Quando i rom eravamo noi
Quando i rom eravamo noi
Anni 20-30. Le donne di Castelnuovo, ma anche del Gabbro,
raccolgono frutta ed ortaggi e con le loro ceste in testa
appaggiate sul "cercine o cuffaro" si mettono in cammino per
raggiungere il vicino centro balneare, attraverso i sentieri
più brevi, ma anche più scoscesi del Poggio Pelato e portare
così a compimento minimi affari. A Nibbiaia hanno uguale
inclinazione al commercio ambulante, ma la loro méta è ancor
più lontana: Livorno. Questa foto di inizio '900 mostra
crudemente la lacerante, misera condizione delle donne che
si presentano vestite di stracci ed anche scalze
trascinandosi dietro i figli, alle ville dei ricchi
villeggianti di Castiglioncello, spesso considerate più
accattone che venditrici.
Ma leggiamo come descrive questo crudele contrasto Viviana
Molinari in Bella Marea (1989)
"A Castiglioncello fra le signore c'era un gran fervore di bontà
e di opere buone. La nonna, le sue facoltose principesse e la
signora Valori (moglie del noto giornalista Aldo Valori, madre
di Bice, futura attrice, di Michele e di Paolo, che si farà
sacerdote e diverrà un sottile indagatore dell'animo umano), si
occupavano alacremente di beneficienza, organizzavano treni per
Lourdes e il centro di smistamento per i bisognosi era villa
"Antonietta", casa nostra... Davanti al cancello di servizio la
nonna aveva fatto costruire delle panchine di marmo dove i suoi
beneficati potevano comodamente attendere che si desse loro
udienza. Riceveva dalla terrazza, attrezzata a cabinet de travail, con mobili che sembravano quelli usati nei palcoscenici
e da lì parlava con i suoi poveri. 'Signora, c'è la
massaggiatrice!'. 'Dille che cominci' diceva la nonna che era
molto distratta. 'Io, intanto, parlo col povero della Colonna e
vengo
subito!'. I bambini handicappati erano soprannominati “bambini
azzurri”; i malati chiamati “figli del sole”, secondo un
suggerimento dato da madre Balsari, ... amica inseparabile della
nonna. Tutti gli altri poveri erano distinti gli uni dagli altri
non dal proprio cognome, ma da quello del loro benefattore...
'Non bisogna guardarli troppo!', diceva mia madre a proposito
dei poveri, accorgendosi di qualche mio interesse di bambina.
Per la verità tutti quei postulanti non suscitavano in me
sentimenti di carità; diffidavo, anzi, di quell'andirivieni che
si svolgeva sotto i miei occhi. Non potevo capire. Vivevo ancora
non contaminata dalle strutture sociali e religiose che
stabilivano una distinzione arbitraria tra bene e male. Non
sapevo cosa significasse il privilegio di classe. Perché e come,
loro fossero poveri e io no... Io vedevo in quella gente
diversità, stravaganza; un modo a me assolutamente sconosciuto
di esistere. Qualche paragone certamente riuscivo a farlo.
Capivo benissimo quanto fossero differenti i miei genitori da
loro, ma ignorando la maggior parte delle cose, non potevo
giudicare se non dal mio piccolo passato; non certo da una
prospettiva etica e, tantomeno, sotto una visuale sociale
caritatevole. Qualche cosa, però, tutta quella gente che si
lavava poco e si vestiva così male, doveva suscitare in me...
profittavo dei poveri della nonna, della soggezione in cui
quella gente versava, in modo astratto, quasi crudele solo per
divertirmi... I contadini del Gabbro e Castelnuovo, zappavano
malignamente la terra degli altri, col cuore in rivolta, ma
senza poter fare nulla. Unica speranza di quegli uomini era
quella di pazientare, di aspettare il momento propizio; intanto
lasciavano che le mogli, i figli, fruissero della carità delle
magnanime villeggianti ai quali portavano la loro frutta. E le
loro donne, con furbizia contadina, lasciando da parte ogni
forma di dignità, andavano a blandire quelle pingui signore con
accattivanti sorrisetti, appena dischiusi su labbra sottili,
cattive. Per poche lire dovevano stare al gioco di chi voleva
tranquillizzare la propria coscienza pagandosi l'ingresso in
paradiso con soccorsi alla chiesa e ai suoi poveri"...Con quel
tipo di carità spirituale le dame castiglioncellesi che, in
definitiva, si privavano di qualche lira superflua,
contrattavano con i loro preti, nientemeno che un posto in
Cielo! “Io sfamo i tuoi poveri, tu aprimi le porte del
Paradiso!”...I gaudenti, come sempre, erano in minor numero dei
miserabili che nascostamente soffrivano. Le piaghe sociali di
un’italietta povera, afflitta da paludismo, pellagra,
tubercolosi, erano una realtà presente, ma ignorata,
dimenticata. I bambini dei poveri crescevano male, erano di
statura bassissima ed ignoranti. Arrivati a una certa età, se
potevano, emigravano. Insufficienti dunque gli sforzi
caritatevoli della nonna e delle sue dame. Né bastavano in alcun
modo le previdenze fasciste, tanto meno quelle ecclesiastiche.
Il Duce, come diversivo, invitava la gioventù a zappare la terra.
(Da:
"Bella Marea" di Viviana Molinari
scaricabile dal sito)
LE GABBRIGIANE
Nei paesi di Gabbro e Castelnuovo, facenti parte del comune di
Rosignano Marittimo a circa metà strada tra Rosignano e Livorno,
c’erano molte donne che facevano la spola tra questa città e la
nostra campagna: erano dette le Gabbrigiane. Esse andavano a
piedi a Livorno, con una canestra in testa, a vendere i prodotti
della corte: polli, conigli e uova raccolti in campagna. Al
ritorno portavano alle massaie campagno le, loro fornitrici,
stoffe, aghi, cotone e tutto l’occorrente per confezionare
vestiti in casa o altro che veniva loro commissionato. Erano
donne (fra loro la più assidua, da noi stimata e benvoluta, era Leonetta, nella foto), che settimanalmente venivano a domicilio e,
con buon carattere, avvicinandosi alle case (queste sempre con
la porta aperta o al massimo chiusa con la sola nottola)
chiamavano le massaie ad alta voce, quasi cantando: “Argene,
Rosa, sora Isola, arriva la Gabbrigiana! Ce l’avete l’ova?”. Per
le massaie questo era il momento per fermarsi, per riposarsi,
per vendere qualche prodotto coltivato o allevato e incassare
qualche spicciolo, ma anche l’occasione per essere messe al
corrente di quanto succedeva in città e nei dintorni. Era una maniera per
socializzare, per riposarsi. Le Gabbrigiane erano anche le
informatrici dell’evoluzione della moda. Anche per merito loro,
seppur molto lentamente, le giovani contadine abbandonarono la
“pezzola” annodata sotto la gola e cominciarono a mettersi il
cappello di paglia a larghe tese che le Gabbrigiane vendevano
dopo averne fatto acquisto a Livorno.
(Da: "Un ragazzo in Toscana
negli anni quaranta" di Piero Santi)
le, loro fornitrici,
stoffe, aghi, cotone e tutto l’occorrente per confezionare
vestiti in casa o altro che veniva loro commissionato. Erano
donne (fra loro la più assidua, da noi stimata e benvoluta, era Leonetta, nella foto), che settimanalmente venivano a domicilio e,
con buon carattere, avvicinandosi alle case (queste sempre con
la porta aperta o al massimo chiusa con la sola nottola)
chiamavano le massaie ad alta voce, quasi cantando: “Argene,
Rosa, sora Isola, arriva la Gabbrigiana! Ce l’avete l’ova?”. Per
le massaie questo era il momento per fermarsi, per riposarsi,
per vendere qualche prodotto coltivato o allevato e incassare
qualche spicciolo, ma anche l’occasione per essere messe al
corrente di quanto succedeva in città e nei dintorni. Era una maniera per
socializzare, per riposarsi. Le Gabbrigiane erano anche le
informatrici dell’evoluzione della moda. Anche per merito loro,
seppur molto lentamente, le giovani contadine abbandonarono la
“pezzola” annodata sotto la gola e cominciarono a mettersi il
cappello di paglia a larghe tese che le Gabbrigiane vendevano
dopo averne fatto acquisto a Livorno.
(Da: "Un ragazzo in Toscana
negli anni quaranta" di Piero Santi)

 le, loro fornitrici,
stoffe, aghi, cotone e tutto l’occorrente per confezionare
vestiti in casa o altro che veniva loro commissionato. Erano
donne (fra loro la più assidua, da noi stimata e benvoluta, era Leonetta, nella foto), che settimanalmente venivano a domicilio e,
con buon carattere, avvicinandosi alle case (queste sempre con
la porta aperta o al massimo chiusa con la sola nottola)
chiamavano le massaie ad alta voce, quasi cantando: “Argene,
Rosa, sora Isola, arriva la Gabbrigiana! Ce l’avete l’ova?”. Per
le massaie questo era il momento per fermarsi, per riposarsi,
per vendere qualche prodotto coltivato o allevato e incassare
qualche spicciolo, ma anche l’occasione per essere messe al
corrente di quanto succedeva in città e nei dintorni. Era una maniera per
socializzare, per riposarsi. Le Gabbrigiane erano anche le
informatrici dell’evoluzione della moda. Anche per merito loro,
seppur molto lentamente, le giovani contadine abbandonarono la
“pezzola” annodata sotto la gola e cominciarono a mettersi il
cappello di paglia a larghe tese che le Gabbrigiane vendevano
dopo averne fatto acquisto a Livorno.
(Da: "Un ragazzo in Toscana
negli anni quaranta" di Piero Santi)
le, loro fornitrici,
stoffe, aghi, cotone e tutto l’occorrente per confezionare
vestiti in casa o altro che veniva loro commissionato. Erano
donne (fra loro la più assidua, da noi stimata e benvoluta, era Leonetta, nella foto), che settimanalmente venivano a domicilio e,
con buon carattere, avvicinandosi alle case (queste sempre con
la porta aperta o al massimo chiusa con la sola nottola)
chiamavano le massaie ad alta voce, quasi cantando: “Argene,
Rosa, sora Isola, arriva la Gabbrigiana! Ce l’avete l’ova?”. Per
le massaie questo era il momento per fermarsi, per riposarsi,
per vendere qualche prodotto coltivato o allevato e incassare
qualche spicciolo, ma anche l’occasione per essere messe al
corrente di quanto succedeva in città e nei dintorni. Era una maniera per
socializzare, per riposarsi. Le Gabbrigiane erano anche le
informatrici dell’evoluzione della moda. Anche per merito loro,
seppur molto lentamente, le giovani contadine abbandonarono la
“pezzola” annodata sotto la gola e cominciarono a mettersi il
cappello di paglia a larghe tese che le Gabbrigiane vendevano
dopo averne fatto acquisto a Livorno.
(Da: "Un ragazzo in Toscana
negli anni quaranta" di Piero Santi)